La sindrome di Ræbenson. Intervista a Giuseppe Quaranta
Uno scrittore, Nino G. D’Attis, intervista un altro scrittore, Giuseppe Quaranta, autore del fortunato “La Sindrome di Ræbenson”, “romanzo filosofico costruito come un thriller ipnotico e immaginifico”.
«Si era scontrato con i limiti della sua disperazione, aveva cercato di espanderli. Non c’era riuscito e aveva dunque rinunciato alla propria identità. Era per questo che voleva essere un altro, altrove».
Uno psichiatra, Antonio Deltito, affetto da un’indecifrabile patologia che gli provoca amnesie, alterazioni della vista, deliri intorno alla presunta esistenza di una razza di immortali. Il suo collega (il narratore senza nome) si avventura in una lunga indagine che lo porterà – in un gioco di riflessi, di doppi, di identità frammentate – a inoltrarsi nei pericolosi labirinti della mente umana, quello spazio interiore in cui è facile smarrirsi e incontrare il proprio fantasma.
L’esordio letterario di Giuseppe Quaranta con La Sindrome di Ræbenson (Atlantide Edizioni, pp. 272, € 18,00) è un’opera singolare nell’attuale panorama italiano: romanzo filosofico costruito come un thriller ipnotico e immaginifico, sorretto da una prosa che attinge in parti uguali all’inchiostro dei classici e a quello delle relazioni cliniche.
L’occasione per fare due chiacchere con l’autore (e medico psichiatra) è nata a margine della presentazione del libro presso la libreria Ubik Spazio Sette di Roma.
Sei stato finalista al Premio Calvino e il tuo libro è stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica. Ora sei impegnato in un giro di presentazioni, occasione questa per raccogliere in presa diretta i riscontri dei lettori. È un aspetto che ti piace o, come alcuni scrittori, faresti volentieri a meno degli impegni promozionali?
Devo dire che la mia coscienza non mi permette di far stampare migliaia di copie a gente che ha creduto in me e mi ha dato fiducia e restarmene adagiato sugli allori del consenso critico. Tutto ciò che può portare alla vendita dei libri è ben accetto, compresa questa intervista. Dormo anche più tranquillo la notte.
Il romanzo si apre con una scena ambientata a Roma, su un terrazzo con vista sui tetti e le cupole della città rischiarati dalla luna. C’è un breve passaggio in cui, parlando della città eterna, si accenna all’ultimo destino, al crepuscolo degli dèi della mitologia norrena. È un’immagine che offre al lettore un primo indizio su quello che sarà il tema centrale della storia, l’ossessione che contagerà i due personaggi principali. L’ho trovata un’intuizione molto bella.
Grazie. Sì, è un’immagine apocalittica che fa da bordone a tutta la storia. Questa tua osservazione mi lusinga, perché di solito è una cosa che si riserva ai classici: quando si legge un classico, infatti, si ha l’impressione che nessuna immagine o fatto siano gratuiti, in particolar modo quello che troviamo nelle prime pagine di un testo. Ricordo che, dopo il breve prologo delle streghe, il Macbeth si apre con la scena di un capitano insanguinato che torna dalla battaglia e qualcuno domanda a corte: “chi è quell’uomo insanguinato”? Ecco, mentre Macbeth va macchiandosi di orrendi delitti, ci continueremo a fare proprio quella domanda. Chi è quell’uomo insanguinato; chi è, cioè, Macbeth?
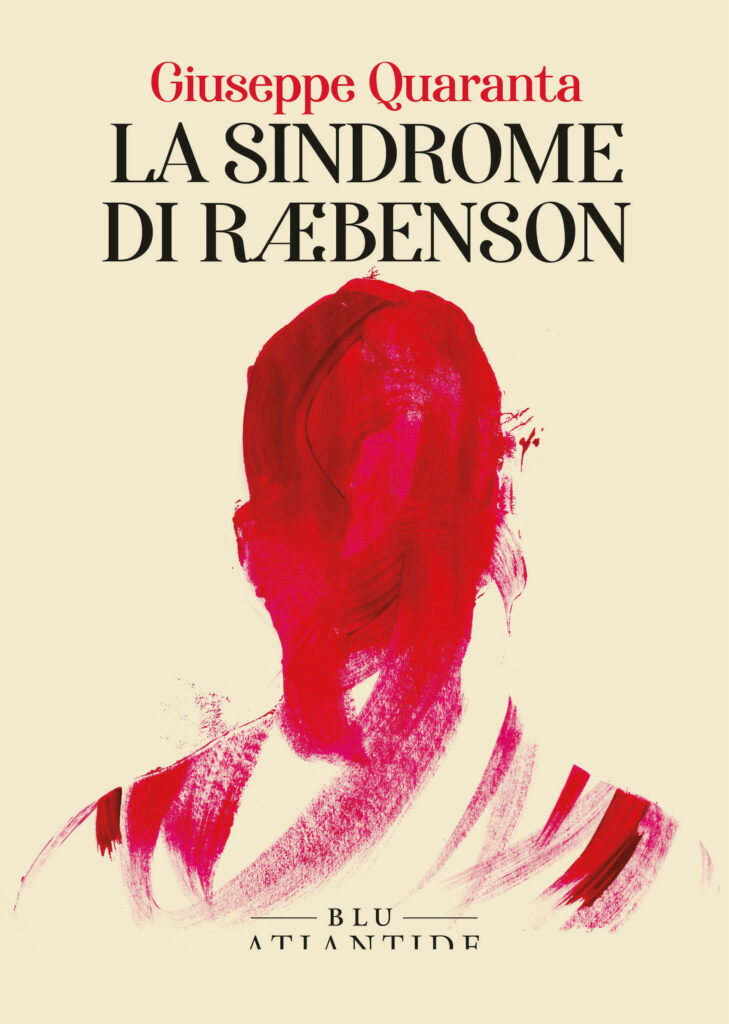
C’è una tensione, una suspense che non abbandona il lettore fino all’ultima pagina. Arrivati alla fine si prova l’impressione di aver letto un thriller o una storia di fantasmi ambientata nei labirinti della mente umana. Sei d’accordo?
Sono molto d’accordo. C’è quella frase terribile di Ibsen che dice che la vita è una lotta disperata con il demonio nelle caverne della mente, e la poesia è il risultato di questa lotta, il giudizio che noi pronunciamo su noi stessi. Nel mio caso, non la poesia, ma il romanzo, che io penso infatti sia una impressione personale e diretta della vita, e si sviluppa a partire da emozioni intime. E questo vale per qualunque genere. Anche la letteratura fantastica nasce da un bisogno, da una necessità, ha una radice emozionale; Wells scrisse L’uomo invisibile perché quando arrivò a Londra dal Kent si sentiva completamente solo, era tubercolotico, molto povero. Nel mio caso, dovevo coniugare il bisogno che avevo di avventura, che trascina necessariamente con sé una certa dose di pathos e concitazione, con la mia metà più oscura, quella che pensa che io sia solo su questa terra e non c’è nessuna avventura, quella tiranneggiata dall’idea della morte e il suo confine con la vita.
Man mano che viene assorbito dalle sue ricerche dedicate alla sindrome e alla misteriosa setta dei raebensoniani, il narratore si trasforma in un detective. Non è Marlowe, né il dolente Sam Spade; a me ha ricordato più il Dean Corso de La Nona Porta di Polanski assillato dalla ricerca della verità a tutti i costi. La sua indagine scientifica occuperà un arco temporale piuttosto ampio, lo porterà a incrociare altre esistenze, altre voci e vicende dolorose e, anche se il lettore non lo vedrà invecchiare, alla fine si comprende che questo chiodo fisso gli ha sottratto molto, praticamente tutto.
Sì, il narratore ha tutte le caratteristiche del monomaniaco. I monomaniaci sono coloro che sacrificano tutte le loro identità alternative per l’unica possibile. Monomaniaco è Sorel, monomaniaco è Achab. Il narratore ha sacrificato la sua vita, i suoi affetti, persino un amore, per dedicarsi al suo lavoro di ricercatore, crede che la felicità gli piomberà addosso quando arriverà a conoscere la verità, ma non sa che, come diceva Cioran, qualsiasi forma di elevazione spirituale presuppone l’inutile, un sapere disinteressato. Quando poi si imbatte nella storia di Deltito è come se un fosfene entrasse nel suo campo visivo, qualcosa lo intacca per sempre. Se sei entrato nel regno dell’ossessione mentale, non te ne puoi sbarazzare facilmente. Da un lato senti che una sola risposta sarebbe soddisfacente (Deltito è un pazzo), ma questa dissolverebbe quella malia mentale, mentre quello che tu vuoi fare è preservarla, proteggerla, e in definitiva appropriartene. Quando te ne appropri, però, quest’ultima scardina ogni assetto precedente, a quel punto non puoi più tornare indietro.
L’immortalità come una maledizione. Poi c’è il motivo del doppio, dell’identità scissa, con tutte le paure e le domande ad esso connessi. Hai detto che l’immagine che ha dato il via al romanzo è quella di una coppia di gemelli.
Quando i gemelli compaiono nel mito, non si sa mai come interpretarli. Ed è proprio questa loro scarsa chiarezza concettuale che mi ha portato a immaginare una sindrome di difficile interpretazione. Una sindrome che fosse irreale, ma non più irreale di molte idee che popolano il nostro universo e hanno infestato la psichiatria, penso ad esempio ai concetti ormai “smantellati” di isteria o schizofrenia (L’invenzione dell’isteria è uno splendido libro di Didi-Huberman). Questa sindrome ha come caratteristica quella di non far perire le persone in cui si manifesta: un dono che però, a conti fatti, per i ræbensoniani è una maledizione. Spesso mi è capitato di confrontarmi con persone che avevano un disturbo mentale e allo stesso tempo qualche talento straordinario (era chiaro che le due cose procedessero insieme), ma in ognuna ho trovato lo stesso tormento, il rifiuto di quella condizione speciale, il desiderio di barattarla con una presunta normalità. Tutta la prima parte del mio libro consiste nei tentativi che Antonio Deltito fa per appropriarsi di una vita normale, nel rifiuto netto dell’immortalità.
Accanto al testo hai voluto inserire delle immagini, dei paratesti a sostegno dei ragionamenti, delle scoperte del narratore. Un gioco che potremmo definire di “fiction accademica”. È qualcosa di affine al lavoro di un illusionista: se riesci a farlo bene diventa credibile al punto da innescare nel lettore una serie di domande: esiste davvero questa sindrome? Sto accusando dei sintomi simili a quelli dei personaggi?
Siamo in un’epoca molto differente rispetto a un secolo o due secoli fa, dove la narrativa, tra le altre cose, era usata per nascondere sotto forma artistica dei tabù. Oggi, invece, siamo in un’era apertamente confessionale, dobbiamo trovare un modo per rivaleggiare con un’abbondanza di fatti reali che hanno spiccate qualità romanzesche. La narrativa ha, insomma, perso il suo carattere naif, come diceva Henry James, non so quanto questo sia un bene o un male, quel che è certo è che un romanzo non è più un romanzo, non si può più trangugiarlo come si fa con un sandwich. Dobbiamo inventare modi per far sì che il lettore creda alle cose che raccontiamo e il miglior metodo, almeno quello che io uso, è elaborare quelle menzogne che abbiamo tra le mani in modo parossistico fino a farle diventare una forma di verità, ancora più intensa di quel che crediamo perché è una verità letteraria, poetica. La terra è blu come un’arancia, diceva Paul Eluard, e questo possono dirlo solo i poeti. Possono convincerci di cose che noi non potevamo vedere o sentire prima che loro ce le rivelassero.
Nel corso della presentazione a Spazio Sette insieme al tuo editor Matteo Trevisani ti ho sentito parlare di Conrad e anche del cinema di David Lynch. Mentre leggevo il romanzo mi sono venuti in mente due nomi: James Ballard e David Cronenberg, uno scrittore e un regista che hanno raccontato le mutazioni, le derive del corpo e della mente.
Mi piacciono molto. Non ero consapevole fossero affiorati nella scrittura di Ræbenson, però se me lo dici ci credo, ed è un bel complimento che metto subito nella sacca dell’ego. In generale, molte suggestioni mi sono arrivate dalla letteratura fantastica, ma anche dalla scienza. La scienza può ampliare l’orizzonte di un romanzo, perché può fornire nuovi argomenti. Aveva ragione E. M. Forster.
Il tuo romanzo è uscito per Atlantide, casa editrice che in questo momento sta pubblicando testi davvero interessanti (il primo che mi viene in mente è Alla ricerca dell’oblio sonoro di Harry Sword) e ha una cura esemplare dei titoli in catalogo, non ultimo l’aspetto della veste grafica. Come è nato e si è sviluppato il tuo rapporto con loro?
Sono arrivato ad Atlantide attraverso la mia agente, Melissa Panarello. Avevo conosciuto Atlantide tempo prima, mi ero imbattuto in due testi molto belli, uno è L’inferno di Barbusse, e l’altro è Riaffiorano dalle terre abissate di Harrison, libro stranissimo e di gran fascino. La scoperta progressiva delle loro pubblicazioni è stato uno dei modi con cui migliorare la mia anima. Sono decisamente onorato di far parte del loro catalogo.



